Santi dell'11 Settembre - Istituto Aveta
Menu principale:
- Home
- Chi siamo
-
La Scuola
- Documenti condivisi
- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Uffici Amministrativi
- Modulistica
- Il mio Santo
-
Il Santuario
-
Madonna Pellegrina
- Pellegrina Anno 1950
- Pellegrina Anno 1977
- Pellegrina Anno 1982
- Pellegrina Anno 1984
- Pellegrina Anno 1985
- Pellegrina Anno 1986
- Pellegrina Anno 1987
- Pellegrina Anno 1988
- Pellegrina Anno 1989
- Pellegrina Anno 1990
- Pellegrina Anno 1991
- Pellegrina Anno 1992
- Pellegrina Anno 1993
- Pellegrina Anno 2005
- Pellegrina Anno 2006
- Pellegrina Anno 2007
- Pellegrina Anno 2008
- Pellegrina Anno 2009
- Pellegrina Anno 2010
- Pellegrina Anno 2011
- Pellegrina Anno 2012
- Pellegrina Anno 2013
- Pellegrina Anno 2014
- Pellegrina Anno 2015
- Storia del Santuario
- Bartolo Longo
- Rivista del Santuario
- Delegati Pontifici
- Gli ex voto
-
Madonna Pellegrina
- Con Gesù
- Meditando
Santi dell'11 Settembre





1 Sant' Adelfio di Remiremont -
 Etimologia: Adelfio = (Adelfo) fratello, dal greco
Etimologia: Adelfio = (Adelfo) fratello, dal greco
Martirologio Romano: Nel monastero di Luxeuil in Burgundia, ora in Francia, transito di Sant’Adelfio, abate del monastero di Remiremont, che lavò a lungo nelle lacrime la discordia di un breve momento.
(Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

2 Beato Baldassarre Velasquez - + 1588
+ 1588
Il mercedario Beato Baldassarre Velàsquez, cadde prigioniero fra i saraceni ribelli a La Muela presso Saragozza in Spagna.
Fu, da questi, minacciato di morte qualora non avesse rinnegato la fede cattolica ma egli li rimproverò severamente delle loro cattiverie e vizi così testimoniando la propria fede fu trafitto da una freccia nell'anno 1588 e assieme a lui similmente vennero trafitti altri 16 martiri.
L'Ordine lo festeggia l'11 settembre.
(Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

3 Beato Bonaventura da Barcellona (Michele Battista Gran) -
Riudoms, Spagna, 24 novembre 1620 -
Michele Battista Gran, nato a Riudomes (Spagna) nel 1620, rimasto vedovo era divenuto frate col nome di Bonaventura di Barcellona.
Fu in diversi conventi spagnoli, dimostrando una profonda spiritualità, ubbidisce allegramente, vive una vita ritirata e mortificata. Chi gli vive accanto è testimone di fatti che hanno del miracoloso e che lasciano intravedere la sua vicinanza a Dio.
Sente che il Signore vuole da lui un impegno particolare per rinnovare lo spirito francescano con l'istituzione dei «Ritiri», un ritorno alla spiritualità e alla povertà francescana delle origini. Si reca a Roma e qui trova un'umanità sofferente e bisognosa.
Da vero figlio di san Francesco aiuta tutti come può e viene ribattezzato «l'apostolo di Roma». La riforma francescana che sta attuando gli attira i consensi delle autorità ecclesiastiche e dagli stessi Papi Alessandro VII e Innocenzo XI, dai quali arriva l'approvazione pontificia agli statuti dei suoi «Ritiri». Morì in San Bonaventura al Palatino nel 1684. (Avvenire)
Martirologio Romano: A Roma, Beato Bonaventura da Barcellona (Michele) Gran, religioso dell’Ordine dei Frati Minori, che, per amore dell’osservanza della regola, istituì in molti luoghi del territorio romano conventi per ritiri spirituali, mostrando sempre grande austerità di vita e carità verso i poveri.
Si era sposato a diciott’anni soprattutto per ubbidire a papà. Michele Battista Gran., giovane spagnolo d’inizio Seicento, si sente decisamente portato alla vita religiosa e negli studi riesce anche bene.
Ma è anche figlio unico di modesti agricoltori, che diventati anziani reclamano il suo aiuto nel lavoro dei campi e gli organizzano la vita, a cominciare dalla moglie. 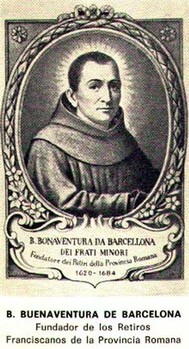 Si sposa dunque, più per ubbidienza che per amore, ma sedici mesi dopo si ritrova già vedovo. Come a dire che l’uomo propone e Dio dispone.
Si sposa dunque, più per ubbidienza che per amore, ma sedici mesi dopo si ritrova già vedovo. Come a dire che l’uomo propone e Dio dispone.
E così il giovanotto, reso maturo dagli eventi, trova il coraggio di far prevalere le sue inclinazioni sulle aspettative dei genitori e, non senza contrasti familiari, a vent’anni se ne ritorna in convento, tra i Minori Francescani.
Non però per diventare sacerdote, perché come San Francesco si sente profondamente indegno, ma, con il nuovo nome di Fra Bonaventura, come umile religioso, che per diciassette anni gira i vari conventi della Catalogna per fare, di volta in volta, il cuoco, il portinaio, l’infermiere o il questuante.
Fra Bonaventura si dimostra un frate che prega molto, ubbidisce allegramente, vive una vita ritirata e mortificata.
E compie cose prodigiose.
Chi gli vive accanto è testimone di fatti che hanno del miracoloso e che lasciano intravedere il suo grado di unione con Dio e la perfezione nella vita religiosa che giorno per giorno si sforza di raggiungere.
Sente che il Signore vuole da lui un impegno particolare per rinnovare lo spirito francescano con l’istituzione dei “Ritiri”, che altro non è che un ritorno alla spiritualità e alla povertà francescana delle origini e allora parte in direzione di Roma.
Strada facendo crescono i nuovi “Ritiri” di cui lui, umile fratello laico, è chiamato ad essere superiore, anche se, come per ogni “riforma” che si rispetti, non gli mancano i contrasti e le difficoltà.
La sua “marcia su Roma” si conclude nella città eterna, dove trova ad attenderlo un’umanità sofferente e bisognosa, afflitta dalle continue epidemie, dalla povertà cronica, dalle scorribande nemiche.
Da vero figlio di San Francesco si fa in quattro per aiutare tutti come può, ed è così sollecito e premuroso che lo ribattezzano, lui, spagnolo purosangue, “l’apostolo di Roma”.
La riforma francescana che sta attuando, oltre alle critiche ed alle ostilità, gli attira anche i consensi delle autorità ecclesiastiche e dello stesso Papa, da Alessandro VII a Innocenzo XI, dai quali arriva anche l’approvazione pontificia agli statuti dei suoi “Ritiri”.
Tutti sono stupiti dei doni di spiritualità e di grazia che si ammirano in quel frate e dei prodigi che si verificano attorno a lui, come la firma di Dio sul suo operato.
A Roma muore, poco più che sessantenne, l’11 settembre 1684 e la riconoscenza dei romani si trasforma subito in venerazione, che S. Pio X ratifica ufficialmente il 10 giugno 1906, proclamando solennemente Beato l’umile Fra Bonaventura da Barcellona. (Autore: Gianpiero Pettiti – Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

4 San Daniele di Bangor -
Martirologio Romano: Nell’isola di Bardsey sulla costa del Galles settentrionale, San Daniele (Deiniol Wyn), vescovo e abate di Bangor. Figlio di un Re e discendente di Coel Godeborg, secondo la Legenda novem lectionum de S. Daniele, episcopo Bangorensi, viene ricordato come il fondatore  del Monastero di Bangor Fawr (Monastero gallese, da non confondere coll’omonimo Monastero irlandese. Secondo una fonte, fondò due Monasteri omonimi: oltre a Bangor Fawr, su terre donate da Re Maelgwn di Gwynedd anche a Bangor-
del Monastero di Bangor Fawr (Monastero gallese, da non confondere coll’omonimo Monastero irlandese. Secondo una fonte, fondò due Monasteri omonimi: oltre a Bangor Fawr, su terre donate da Re Maelgwn di Gwynedd anche a Bangor-

5 Sant' Elia Speleota -
Reggio Calabria, 863 -
Emblema:
Martirologio Romano: Nel monastero di Aulinas in Calabria, Sant’Elia, detto lo Speleota, insigne cultore della vita eremitica e cenobitica.
Sant’Elia Speleota (così chiamato per distinguerlo dall’omonimo profeta e da S. Elia Juniore) nacque a Reggio Calabria nel 863 da ricchi genitori, Pietro e Leonzia. All’età di diciotto anni, la madre Leonzia gli propose di sposare una nobile giovinetta e di metter su famiglia. Elia, però, rifiutò la proposta e fuggì di casa andando prima a Taormina di Sicilia, a far penitenza, e poi si diresse in pellegrinaggio a Roma. Qui, nelle vicinanze della città eterna, prese l’abito monastico di S. Basilio Magno (forse nell’abbazia di Grottaferrata).
All’età di diciotto anni, la madre Leonzia gli propose di sposare una nobile giovinetta e di metter su famiglia. Elia, però, rifiutò la proposta e fuggì di casa andando prima a Taormina di Sicilia, a far penitenza, e poi si diresse in pellegrinaggio a Roma. Qui, nelle vicinanze della città eterna, prese l’abito monastico di S. Basilio Magno (forse nell’abbazia di Grottaferrata).
Tornato a Reggio di Calabria, Elia fuggì di nuovo, stavolta col monaco Arsenio, diretto a Patrasso in Oriente. Nel frattempo i Saraceni irruppero in Calabria facendo stragi e schiavi.
Al ritorno da Patrasso, Sant’Elia Speleota (=abitatore di grotte), insieme ai monaci Cosma e Vitale, si ritirò a condurre vita di penitenza nella grotta di Melicuccà.
Qui, ben presto, gli abitanti dei paesi vicini, attratti dalla sua fama di santità, venivano a visitarlo, ascoltarlo, a ricevere da lui conforto e incoraggiamento.
L’11 settembre del 960, quando aveva già 97 anni, Elia morì. Fu sepolto nel sepolcro che lui stesso aveva scavato nella grotta con le sue mani.
Lì, il suo corpo rimase sepolto fino al 2 agosto 1747 quando furono scoperte le sue ossa. In quell’occasione, come attesta l’atto pubblico rogato dal notaio Fantoni Carmelo il 12 agosto di quell’anno, Antonio Germanò, giovane di Melicuccà gravemente ammalato, alla sola vista delle ossa di sant’Elia guarì istantaneamente.
Il Santo viene festeggiato l’11 settembre. (Autore: Francesco Roccia – Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

6 San Felice, Regola ed Essuperanzio -
m. Zurigo (Svizzera), fine III secolo
I Santi Felice e Regola, ed Essuperanzio loro servo, sono stati legati da improbabili leggende alla celebre Legione Tebea e, scampati all’eccidio di Agauno (odierna Saint-
Emblema: Palma, Testa decapitata
Martirologio Romano: A Zurigo nell’odierna Svizzera, santi martiri Felice e Regola.
Santi Felice, Regola ed Essuperanzio, martiri
In data odierna la città svizzera di Zurigo ricorda i suoi celesti patroni: i santi Felice e Regola ed il loro servo Essuperanzio. Assai incerte sono le poche notizie tramandate sul loro conto, ma per meglio comprendere l'origine del culto di questi intrepidi testimoni della fede cristiana, occorre ripercorrere brevemente la vicenda della celebre Legione Tebea, alla quale la pietà popolare ha leggendariamente arruolato i santi oggi in questione.
Il nuovo Martyrologium Romanum cita al 22 settembre: “A Saint-
Nel Vecchio Continente se ne contano all'incirca 400, così suddivisi geograficamente: 58 in Piemonte, 15 in Lombardia, 2 in Emilia, 10 in Francia, 325 in Germania, 5 in Svizzera e 2 in Spagna. E questo non è purtroppo che un incompleto e sommario elenco. A questa folta schiera, creata a dir la verità dalla fantasia di alcuni agiografi che nulla conoscevano di certo relativamente a questi antichi martiri e preferirono così agganciarli all'ormai proliferante ed avvincente Legione, appartengono anche Felice e Regola. Già solo il sesso della seconda può iniziare a creare qualche dubbio circa la reale appartenenza al famoso esercito, a meno che non si voglia optare per l'esistenza di un'eroina del tipo di Santa Giovanna d'Arco.
dir la verità dalla fantasia di alcuni agiografi che nulla conoscevano di certo relativamente a questi antichi martiri e preferirono così agganciarli all'ormai proliferante ed avvincente Legione, appartengono anche Felice e Regola. Già solo il sesso della seconda può iniziare a creare qualche dubbio circa la reale appartenenza al famoso esercito, a meno che non si voglia optare per l'esistenza di un'eroina del tipo di Santa Giovanna d'Arco.
Il testo più antico riportante la leggenda dei due presunti santi fratelli risale all'VIII secolo. Qui Felice e Regola vengono appunto ricollegati con un legame non molto chiaro alla Legione Tebea. Una volta scappati dal grande eccidio, i due si sarebbero rifugiati in un primo tempo a Glaris ed infine presso Zurigo. Si dedicarono dunque ad evangelizzare gli abitanti della città, per poi battezzarli al sicuro nelle foreste. Furono però scoperti ed il governatore romano li condannò a morte. Un miracolo simile a quello dei martiri tebei Urso e Vittore, ma ancor più spettacolare, ebbe luogo sotto gli occhi esterrefatti dei soldati che li avevano decapitati al bordo della Limmat. I corpi presero nelle loro mani le teste cadute per terra e le portarono sino al luogo della loro sepoltura, su una vicina collina. Questi gloriosi martiri si meritarono così l'appellativo di “cefalofori”, cioè portatori di testa, atto a conferire alla loro leggenda un profondo significato teologico: i martiri, morti per decapitazione, camminano ostentatamente verso la nuova vita, verso la comunione con tutti gli altri santi.
Nell'853 Ildegarda, figlia di Luigi II il Germanico, vi fondò un convento femminile la cui chiesa fu più tardi rimpiazzata dal Grossmunster. Con la costruzione di quest'ultimo, le religiose passarono sull'altra riva, in un nuovo convento che prese il nome di Fraumunster.
Una tardiva quanto improbabile leggenda del XIII secolo racconta di un certo Essuperanzio che, presunto servitore di due fratelli, si sarebbe a loro unito nella professione della fede cristiana subendo il medesimo martirio e raggiungendo anch'egli la tomba reggendo la propria testa con le mani.
Al tempo della Riforma protestante, le reliquie dei tre santi furono trasferite ad Andermatt, ove sono conservate nella chiesa parrocchiale.
Tutta questa colorita leggenda è stata meravigliosamente rappresentata negli anni '30 e '40 del secolo scorso sui muri di due chiostri rispettivamente romanico e gotico di Fraumunster, per mano del pittore di Zurigo Paul Bodmer. Nell'ultimo affresco l'imponente processione della “translatio” delle reliquie dei tre martiri. Un gran bell'omaggio della città di Zwingli!
Il presupposto che essi abbiano militato nella Legione Tebea ha automaticamente conferito loro la presunta nazionalità egiziana e ciò ha contribuito alla diffusione del culto anche presso la Chiesa Copta, che venera dunque specificatamente non solo San Maurizio ma anche tutti quei suoi leggendari compagni il cui ricordo si è diffuso in un qualche piccolo santuario d'Europa.
L'iconografia relativa ai tre martiri, oltre a presentarli talvolta con gli attributi tipici dei soldati tebei quali la palma del martirio, la spada, lo stendardo con croce rossa in campo bianco e la Croce Mauriziana sul petto, li raffigura prevalentemente nell'atto di reggere miracolosamente con le mani il proprio capo distaccato dal corpo a causa della decapitazione subita.
Il nuovo Martyrologium Romanum commemora i santi martiri Felice e Regola in data odierna, 11 settembre, senza però nulla esplicitare circa la loro vita, tranne la città svizzera di Zurigo quale centro del loro culto. (Autore: Fabio Arduino -

7 Beato Francesco Giovanni Bonifacio -
Pirano, Croazia, 7 settembre 1912 -
Nato a Pirano (Istria) nel 1912, da una famiglia umile e profondamente cristiana, e secondo di sette figli, Francesco ricevette l'ordinazione sacerdotale il 27 dicembre 1936, nella cattedrale di San Giusto a Trieste.
Dopo un primo incarico a Cittanova, assunse la responsabilità della curazia di Villa Gardossi, che raccoglieva diverse frazioni sparse nella zona di Buie. Don Francesco si fece subito amare, promuovendo numerose attività, visitando le famigle, gli ammalati, e donando quel poco che aveva ai poveri. Il suo impegno lo rese un prete troppo scomodo per la propaganda antireligiosa della Jugoslavia di allora, ma nonostante le intimidazioni proseguì fino alla fine per la sua strada. E' la sera dell'11 settembre 1946 e don Francesco Bonifacio sta rincasando da Grisignana. A un certo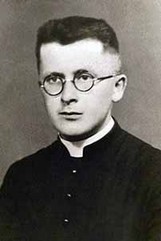 punto viene fermato da due uomini della guardia popolare. Chi li vide raccontò che sparirono insieme nel bosco. Il fratello, che lo cercò immediatamente, venne incarcerato con l’accusa di raccontare delle falsità. Per anni la vicenda è rimasta sconosciuta, finché un regista teatrale è riuscito a contattare una delle guardie popolari che avevano preso don Bonifacio. Quest'ultimo raccontò che il sacerdote era stato caricato su un’auto, picchiato, spogliato, colpito con un sasso sul viso e finito con due coltellate prima di essere gettato in una foiba. Da allora i suoi resti non sono stati mai più ritrovati.
punto viene fermato da due uomini della guardia popolare. Chi li vide raccontò che sparirono insieme nel bosco. Il fratello, che lo cercò immediatamente, venne incarcerato con l’accusa di raccontare delle falsità. Per anni la vicenda è rimasta sconosciuta, finché un regista teatrale è riuscito a contattare una delle guardie popolari che avevano preso don Bonifacio. Quest'ultimo raccontò che il sacerdote era stato caricato su un’auto, picchiato, spogliato, colpito con un sasso sul viso e finito con due coltellate prima di essere gettato in una foiba. Da allora i suoi resti non sono stati mai più ritrovati.
I suoi piccoli amici lo chiamano “el santin”. Non per derisione, ma perché tale a loro sembra quel ragazzino semplice, tanto generoso, buono fino all’accesso. Entra a 12 anni nel seminario di Capodistria e, se non eccelle negli studi, certamente si distingue per la bontà e per la vita di intensa preghiera. I seminaristi finiscono per ribattezzarlo “santo pacifico”, per la pazienza e il sentimento che mette nell’instaurare buoni rapporti con tutti, eliminare i contrasti, alimentare la spiritualità dei suoi compagni anche durante le vacanze. Prete a 24 anni, dopo tre anni di tirocinio, nel 1939 lo mandano come cappellano a Villa Gardossi, 1300 anime disseminate in casupole e casolari lungo i pendii collinari tra i paesi di Buie e Grisignana. Il giovane prete si butta a capofitto nel lavoro, riorganizzando il catechismo, l’Azione Cattolica, il gruppo chierichetti, la cantoria parrocchiale. Soprattutto cura con particolare attenzione il rapporto personale con i suoi parrocchiani: tutti i pomeriggi sono dedicati al contatto diretto con la sua gente, che va a cercare di casa in casa, soprattutto dove immagina ci sia qualche malato da confortare o qualcuno da incoraggiare. Non scoppia di salute, a giudicare dall’asma che lo tormenta da sempre e dalla tosse insistente e cronica che rivela i suoi tanti problemi bronchiali e polmonari. Eppure, con qualsiasi tempo, appoggiato al suo bastone e accompagnato dal suo cane, percorre in lungo e in largo la sua valle, fermandosi solo di tanto in tanto a riprendere fiato.La mamma e il fratello minore si trasferiscono con lui in canonica, per condividere la sua vita semplice e povera in quella valle in cui manca l’elettricità, l’acqua potabile bisogna andarla cercare in sorgenti distanti da casa, la terra è avara. “Tirano cinghia” anche loro, accontentandosi di molte minestre, di polente quasi quotidiane e di uova. Sempre che lui, il pretino che si fa tutto a tutti, non le porti prima in qualche casa dove le bocche da sfamare sono troppe e non tutti hanno qualcosa da mettere sotto i denti. Un prete così si fa amare, ispira simpatia, attira consensi. Forse anche troppi, soprattutto dopo l’8 settembre 1943, quando si espone in prima persona per evitare inutili carneficine e rappacificare gli animi, rivelandosi davvero quel “santo pacifico” che i suoi compagni avevano conosciuto negli anni di seminario. E tale continua ad esserlo anche a guerra finita, quando l’Istria vive uno dei più bui momenti della sua storia passando di fatto sotto la diretta amministrazione del governo iugoslavo. Che avvia un’opera di vera e propria pulizia etnica, con esecuzioni sommarie e migliaia (4000 per le fonti ufficiali, forse addirittura 20000) di giustiziati “fatti sparire” nelle foibe, cioè nelle cavità carsiche di cui il territorio è ricchissimo. Sorprendente il coraggio sfoderato dal prete malaticcio e timido solo all’apparenza. Esclusivamente in nome del vangelo, e non di vaghe teorie pacifiste, continua ad esplicitamente ammonire ed istruire, dall’ambone e a catechismo, negli incontri personali e nelle adunanze pubbliche. Dà fastidio, quel prete, e cominciano a fioccare avvertimenti e minacce. Continua imperterrito in nome di Cristo, limitandosi a consultare il suo vescovo, che lo consiglia di essere prudente e di limitare la sua attività all’interno della chiesa, evitando ogni presa di posizione pubblica. “Era quello che pensavo”, dice il prete, “ma aspettavo che mi venisse imposto per obbedienza, perché solo così sono certo che questa è la volontà di Dio”. Ma ormai la sua sorte è segnata: lo aspettano l’11 settembre 1946, al ritorno da Grisignana, dov’è andato a confessarsi. Lo vedono sparire nella boscaglia, sotto la scorta di alcune “guardie del popolo” e da quel momento nessuno saprà più nulla di lui. Solo negli ultimi anni un regista teatrale è riuscito a mettersi in contatto con una di quelle “guardie” ed a ricostruire le sue ultime ore: sequestrato, spogliato, insultato, torturato e umiliato, viene riempito di botte, preso a sassate e finito poi con due coltellate. I suoi resti a tutt’ora non sono stati identificati, perché probabilmente il cadavere è stato fatto sparire, “infoibato” come quello di tanti altri innocenti. Il prossimo 4 ottobre don Francesco Bonifacio verrà proclamato beato, riconoscendo che la sua morte è avvenuta in “odium fidei”, cioè in odio alla sua fede, al Vangelo, alla chiesa e al suo ministero sacerdotale, svolto con troppo coraggioso zelo. (Autore: Gianpiero Pettiti -

8 Beato Francesco Mayaudon -
Martirologio Romano: In una nave all’ancora davanti alla costa francese presso Rochefort, beato Francesco Mayaudon, sacerdote e martire, che, arrestato durante la rivoluzione francese per il suo sacerdozio e tenuto in un galera, morì infine consunto dalla cancrena.
Giaculatoria -

9 Beati Gaspare Koteda, Francesco Takeya e Pietro Shichiemon -
Martirologio Romano: A Nagasaki in Giappone, beati martiri Gaspare Koteda, catechista, e i bambini Francesco Takeya e Pietro Shichiemon, che, nello stesso luogo e con la stessa fermezza dei loro padri, che avevano subito il giorno prima il martirio, furono anch’essi sottoposti per Cristo al supplizio della decapitazione.
Giaculatoria -

10 San Giovanni Gabriele Perboyre -
Puech, Francia, 1802 -
Nato a Montgesty nel 1802 e ordinato sacerdote a Parigi nel 1826, Giovanni Gabriele Perboyre desiderando ardentemente di darsi alle missioni estere si recò in Cina e nel 1832 approdò a Macao. Qui esercitò il suo apostolato tra i cristiani nonostante i pericoli della persecuzione. Tradito da uno dei suoi discepoli, fatto prigioniero, fu torturato a lungo e subì il martirio a Outchanfou l'11 settembre del 1840. Tra i cristiani rimasti fedeli, alcuni presero il corpo e gli diedero sepoltura nel luogo della sua predicazione, dove rimase finché non venne traslato nella Casa Madre della Congregazione dei Preti della Missione (Lazzaristi). Fu beatificato il 10 novembre del 1889 e fu canonizzato il 2 giugno del 1996. La sua memoria liturgica ricorre l'11 settembre. (Avvenire)
Emblema: Palma
Martirologio Romano: Nella città di Wuchang nella provincia dello Hebei in Cina, san Giovanni Gabriele Perboyre, sacerdote della Congregazione della Missione e martire, che per predicare il Vangelo assunse un aspetto conforme alle consuetudini del luogo, ma allo scoppio della persecuzione fu sottoposto durante una lunga carcerazione a varie torture e, infine, appeso a una croce e strangolato con un laccio.
persecuzione fu sottoposto durante una lunga carcerazione a varie torture e, infine, appeso a una croce e strangolato con un laccio.
La sua Diocesi era Cahors. Il suo comune era Puech. La sua parrocchia era il borgo di Mongesty. Lì, il 6 gennaio 1802, figlio primogenito di Pietro Perboyre e di Maria Rigal, nacque Jean-
Dentro il cuore, il giovanissimo Jean-
Suo fratello Louis entra nel 1816 nel Seminario di Montauban (Tarn-
Ma in Seminario, si appassiona alla vita religiosa, sulle orme del grande Santo della carità. Allora decide di rimanervi e chiede di essere ammesso alla Congregazione della Missione. È accettato e si dimostra subito un novizio modello, esemplare nella preghiera, nell’obbedienza e nella mortificazione: “Gesù merita tutto: perché non dargli tutto?”.
Il 28 dicembre 1820, offre a Dio i santi voti. Ha 18 anni e comincia a studiare teologia nella Casa-
Ha un forte ascendente sugli altri: per questo, è mandato a insegnare ai ragazzi nel collegio San Vincenzo di Mont-
Il 23 settembre 1826, è ordinato sacerdote nella cappella della Casa-
Obbedisce e si impegna al massimo, ma P. Jean-
Finalmente esaudito, il 21 marzo 1835 salpa dal porto di Le Havre, diretto in Cina. Il 29 agosto seguente approda a Macao: lì si ferma qualche mese per intraprendere lo studio della lingua cinese, prima di essere inviato nella provincia centro-
Nel gennaio 1838, è trasferito nella provincia di Hupeh, dove ancora più intensa si fa la sua attività missionaria. Nelle sue predicazioni e nelle sue conferenze spirituali, annuncia: “Esiste una sola realtà necessaria: Gesù Cristo. Il Signore Gesù ha detto: Io sono la Via, la Verità, la Vita. Non ci resta che camminare per questa via. Per non essere distolti da questo proposito, ci occorre una luce che rischiari il cammino. Questa luce non può essere che Lui, Gesù, la Verità in persona: Lui stesso ha detto che chi lo segue non cammina nelle tenebre, ma possiede la luce della vita”.
Scoppia in Cina, la persecuzione anti-
Durante la persecuzione, il Padre viene tradito da un vile cristiano che sedotto dalla taglia posta sul missionario, rivela il suo nascondiglio.
Il Padre viene catturato a Tcha-
In quel triste periodo, P. Jean-
Lui, il missionario ardente, ormai vicino a essere sacrificato, dalla sua fanciullezza, aveva sempre fatto così: essere conforme a Gesù.
La ratifica dell’imperatore giunse al mattino dell’11 settembre 1840. A mezzogiorno, il P. Jean-
Le sue spoglie mortali, deposte sulla “Montagna rossa”, il cimitero della città dove era stato giustiziato, poterono essere traslate in Francia nel 1860 e deposte nella Casa-
In una sua conferenza spirituale, come leggiamo nella Liturgia delle Ore il giorno della sua festa, l’11 settembre, egli aveva detto, tutto cristocentrico, così com’era: “Teniamo sempre Gesù Cristo davanti agli occhi, cogliamo i suoi sentimenti intimi e appropriamoci delle sue virtù, del suo stile, della sua vita”. (Autore: Paolo Risso -

11 Beato Giuseppe Maria Segura Penades - Schede dei gruppi a cui appartiene:
Schede dei gruppi a cui appartiene:
“Beati 233 Martiri Spagnoli di Valencia” Beatificati nel 2001
“Martiri della Guerra di Spagna”
Martirologio Romano: Nel villaggio di Genovés nel territorio di Valencia sempre in Spagna, Beato Giuseppe Maria Segura Penadés, sacerdote e martire, che nella stessa persecuzione versò il sangue per Cristo.
(Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

12 San Leudino di Toul -
Martirologio Romano: A Toul in Austrasia, ora in Francia, san Leudíno, vescovo, che visse dapprima da uomo sposato e prese poi la decisione di ritirarsi a vita monastica, al pari di sua moglie Odilia. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

13 Beato Ludovico IV -
28 ottobre 1200 -
Figlio primogenito del langravio Ermanno I e di Sofia di Baviera, nacque il 28 ottobre 1200.
Aveva appena undici anni allorché lo fidanzarono con la quattrenne Elisabetta di Ungheria, la quale visse da allora in poi alla corte di Turingia, divenendo in seguito il loro amore uno dei piú belli che la storia conosca. Malgrado l'opposizione :alle nozze dei vassalli e dei consiglieri che le ritenevano politicamente insignificanti, L., fedele alla parola data alla sua "amica soror", sposò Elisabetta nel 1221. Dal loro matrimonio nacquero tre figli: Ermanno, il 28 marzo 1222; Sofia, il 20 marzo 1224 e la beata Gertrude, che venne alla luce diciotto giorni dopo la morte del padre.
Quando Elisabetta si dedicò alla pratica del francescanesimo, nessuno poteva comprenderla e tuttavia Ludovico permise le sue beneficenze verso i poveri. Nel 1226 egli fece venire a corte, quale severo confessore della sua sposa e come suo proprio consigliere, il predicatore delle  crociate Corrado di Marburgo. La profondità del suo amore verso Elisabetta e del suo sentimento religioso è dimostrata dal fatto che egli non tentò ai di porre limiti alle pratiche ascetiche di lei.
crociate Corrado di Marburgo. La profondità del suo amore verso Elisabetta e del suo sentimento religioso è dimostrata dal fatto che egli non tentò ai di porre limiti alle pratiche ascetiche di lei.
Ludovico così ci appare, da un lato, come uno sposo esemplare e un devoto cristiano; d'altra parte, egli è il langravio che vigila gelosamente sui propri diritti. Successe a suo padre nel governo nel 1217. A diciotto anni, appena fatto cavaliere, fu scomunicato dal vescovo Sigfrido II di Magonza in seguito a contese territoriali e scese in campo contro di lui; la riconciliazione avvenne in Fulda il 20 giugno 1219. Alla morte del margravio di Meissen, marito di una sua sorellastra, Jutta, il 17 febbraio 1221, Ludovico fu coinvolto nelle lotte per l'eredità e scomunicato una seconda volta; nuovamente vittorioso, fu piú tardi dall'imperatore investito del feudo di Meissen. Intraprese nel 1225 una spedizione militare in Slesia e nell'anno seguente passò nell'Italia del Nord con Federico II, guadagnandosi con la sua fedeltà di vassallo l'amicizia dell'imperatore, e ritornò in patria con l'onorevole incarico di nominare reggente dell'impero il duca di Baviera.
Già nel 1224, probabilmente, aveva preso la croce, e la ricevette una seconda volta nel 1227 a Hildesheim, dalle mani del vescovo Corrado. Il 24 giugno a Schmalkalden si congedò dai suoi dopo aver fatto rappresentare alla Wartburg il mistero della Passione: soltanto Elisabetta, che tanto poco aveva potuto vivere con lui, lo accompagnò fino al confine della Turingia.
Durante la crociata, morì di febbri in Otranto il 11 settembre 1227. Le sue spoglie furono portate a Reinhardsbrunn nel sepolcro di famiglia all'inizio del 1228 dai suoi vassalli, nel viaggio di ritorno dalla Terra Santa.
Ludovico ebbe insigni qualità, anche se le fonti agiografiche le esagerano: fu un principe saggio che seppe conservare, nonostante le imprese guerriere, il suo paese in una relativa pace interponendosi piú d'una volta come mediatore di pace anche presso altri. Il libro VI della sua Vita enumera, agli anni 1233 e 1292-
La prima serie apparve improvvisamente quando si discuteva la canonizzazione di Elisabetta; la seconda, quando i monaci di Reinhardsbrunn, dopo l'incendio del loro monastero nel 1292, volevano metter riparo ai danni incoraggiando un grande concorso di pellegrini.
Anche se tali miracoli non sono storicamente certi, la loro invenzione testimonia tuttavia della grande venerazione, che lo fece denominare "il Santo", tributata dal popolo a Ludovico e alla sua sposa e perciò egli è ricordato anche in tutte le opere agiografiche, sebbene ufficialmente il suo culto non sia mai stato confermato. Il giorno della sua commemorazione è l'11 settembre.
Nell'arte lo troviamo prevalentemente raffigurato nei cicli della Vita di s. Elisabetta. Spesso si rappresenta Elisabetta che cura un malato, mentre L. vede in esso il crocifisso. Ricorrono sempre le scene del suo fidanzamento, dell'investitura a cavaliere, e soprattutto dell'addio a Elisabetta e della sua partenza di crociato. (Autore: Konrad Kunze -

14 San Martiniano -
Scheda del Gruppo cui appartiene:
"San Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni" -
Le reliquie del martire tebeo San Martiniano erano un tempo conservate sotto l’altar maggiore della cattedrale di Torino, ma poi vennero traslate in un’altra chiesa cittadina. Una sua reliquia è venerata nella chiesa parrocchiale di Pecco, paesino della Val Chiusella nel Canavese che lo venera quale celeste patrono. La memoria di San Martiniano era un tempo celebrata al 5 dicembre nell’Arcidiocesi di Torino.
Patronato: Pecco (TO)
(Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

15 Santi Matteo e Gusmeo -
Gli storici riportano due versioni sulla vita dei patroni di Gravedona sul Lario (Como), luogo dove, in ogni caso, subirono il martirio. Secondo la prima essi furono compagni dei santi Fedele e Carpoforo, sfuggiti in un primo tempo alle persecuzioni di Massimiano. Un’altra li considera soldati scampati all’eccidio della legione Tebea. Dopo secoli di oblio, i loro corpi furono ritrovati l’11 settembre 1248 in località Pozzano di Gravedona e deposti nella chiesa di San Fedele, che nel 1533 venne ricostruita e intitolata a loro. Nel 1608 la volta fu affrescata da Gianmauro della Rovere, detto il Fiammenghino. (Avvenire)
Etimologia: Matteo = uomo di Dio, dall'ebraico
Emblema: Palma
Vi sono due versioni, riportate dagli storici, che riguardano la Vita dei due santi. La prima li classifica come compagni di s. Fedele e di s. Carpoforo sfuggiti alla persecuzione di Massimiano e rifugiati a Gravedona sul Lario dove furono catturati e uccisi; la seconda, visto la mancanza assoluta dei loro nomi nelle ‘Vite’ dei santi Carpoforo e Fedele, li considera soldati superstiti dell’eccidio della gloriosa legione Tebea, i quali scampati con la fuga , furono scoperti a Gravedona e lì furono martirizzati.
Perso il ricordo del luogo della loro sepoltura, solo l’11 settembre 1248 in località Pozzano di Gravedona, furono ritrovati i loro corpi e deposti nell’antichissima chiesa di Fedele che in seguito fu ricostruita e reintitolata ai due santi, consacrata nel 1250 dal vescovo Uberto.
Il culto è stato continuo e costante, lo dimostra la cura del loro sepolcro che nel secolo XVI era sollevato sul pavimento al centro della chiesa e protetto da cancelli.
Nel 1637 le reliquie furono trasferite sotto l’altare maggiore in una nuova urna marmorea. La volta della chiesa fu affrescata nel 1608 da Gianmauro della Rovere detto il Fiammenghino, rappresentante la gloria dei due santi.
Da tempo immemorabile Matteo e Gusmeo sono stati nominati patroni di Gravedona, che li festeggia ogni anno all’11 settembre. (Autore: Antonio Borrelli -

16 San Pafnuzio - Martirologio Romano: Commemorazione di san Pafnuzio, vescovo in Egitto: fu uno di quei confessori della fede, condannati alle miniere sotto l’imperatore Galerio Massimino, dopo che fu loro cavato l’occhio destro e tagliato il tendine del piede sinistro; prese in seguito parte al Concilio di Nicea, dove lottò strenuamente per la fede cattolica contro gli ariani. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Martirologio Romano: Commemorazione di san Pafnuzio, vescovo in Egitto: fu uno di quei confessori della fede, condannati alle miniere sotto l’imperatore Galerio Massimino, dopo che fu loro cavato l’occhio destro e tagliato il tendine del piede sinistro; prese in seguito parte al Concilio di Nicea, dove lottò strenuamente per la fede cattolica contro gli ariani. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

17 San Paziente di Leone -
m. 480
Nella diocesi di Lione in Francia, si impegnò a fondo nell'apostolato di conversione degli eretici e di assistenza ai bisognosi.
Martirologio Romano: A Lione in Francia, san Paziente, vescovo, che, mosso da carità, distribuì gratuitamente il frumento alle città disposte lungo il Rodano e la Saône per soccorrere le popolazioni oppresse dalla fame e si impegnò a fondo in un apostolato di conversione degli eretici e di cura dei bisognosi. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

18 Beato Pietro de Alcantara (Lorenzo) Villanueva Larrayoz -
Schede dei Gruppi a cui appartiene: “Beati Martiri Spagnoli Fatebenefratelli” -
“Martiri della Guerra di Spagna” -
Osinaga, Spagna, 20 luglio 1881 -
Il B. Fra Pietro d'Alcantara Villanueva, nato nel 1881 a Osinaga (Navarra) e fattosi religioso a Ciempozuelos, fu arrestato dai miliziani il 4 settembre 1936 a Barcellona nella famiglia presso cui aveva trovato ospitalità, e fucilato una settimana dopo.
A chi gli raccomandava di occultare il suo stato religioso, rispondeva: "Questo mai! Non vi è cosa più bella che morire per Cristo!
Se mi daranno una o due fucilate andrò più presto al cielo!". Fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1992.
Martirologio Romano: A Barcellona in Spagna, Beato Pietro de Alcántara (Lorenzo) Villanueva Larráyoz, religioso dell’Ordine di San Giovanni di Dio e martire, che patì il martirio in quanto religioso durante la persecuzione contro la fede. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

19 Santi Proto e Giacinto -
I Santi Proto e Giacinto furono sepolti nel cimitero di Bassilla (poi di San Ermete). Nel 1845 le loro ossa furono trovate in un cubicolo che papa Damaso aveva fatto ripulire dalla terra franata e in cui aveva fatto porre una lapide che ricordava come Proto e Giacinto fossero fratelli martiri. La tradizione narra la loro vita in modo leggendario. Essi sarebbero stati due fratelli cristiani eunuchi, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. Convertita al cristianesimo, Eugenia avrebbe ceduto i due giovani alla nobile Bassilla, convertitasi a sua volta grazie ai loro insegnamenti. Denunciati dal fidanzato di quest'ultima, sarebbero stati tutti martirizzati. Al di là della leggenda, è certo che la loro esistenza e il loro martirio sono stati storicamente comprovati.
Emblema: Palma
Martirologio Romano: A Roma nel cimitero di Basilla sulla via Salaria antica, deposizione dei santi martiri Proto e Giacinto, che il papa san Damaso celebrò nei suoi versi, recuperando i loro tumuli nascosti sotto terra. In questo luogo, circa quindici secoli dopo sono stati nuovamente ritrovati il sepolcro intatto di san Giacinto e il suo corpo consumato dal fuoco.
La storicità dei due martiri è un fatto indiscusso: la loro memoria è infatti celebrata nella Depositio martyrum di Roma, nel Sacramentario Gelasiano (ms. di S. Gallo), nel Gregoriano, in vari 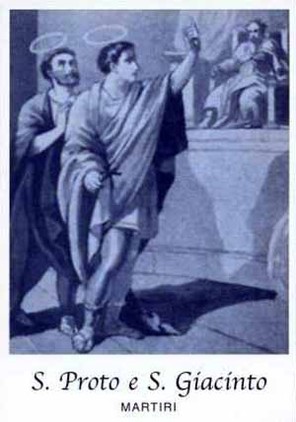 Itinerari (Salisburgense, Epitome de locis sanctis...) e nel Calendario marmoreo napoletano.
Itinerari (Salisburgense, Epitome de locis sanctis...) e nel Calendario marmoreo napoletano.
Proto e Giacinto erano stati sepolti nel cimitero di Bassilla (poi di Sant' Ermete) in un cubicolo che papa Damaso, nel sec. IV, fece ripulire dalla terra franata e dotare di una scala d'accesso e di un lucernario, ricordando il fatto in una lapide ove parlava del sepolcro dei martiri già nascosto sub aggere montis e da lui reso accessibile: quindi rivolgendosi ai due santi scriveva:
Te Protum retinet melior sibi regia coeli
sanguine purpureo sequeris yacinthe probatus
germani fratres animis ingentibus ambo.
Htc victor meruit palman prior ille coronam
Successive riparazioni furono apportate al sepolcro come ricordano alcune iscrizioni ed il Lib. Pont. (I, p. 261), testimonianze di un culto assai diffuso.
Quando nei secc. VIII-
Il 21 marzo 1845, infatti, uno scavatore mise in luce una lastra con questa iscrizione: «dp III idus septebr Yacinthus martyr» rimasta al suo posto originario; non molto distante fu ritrovato un frammento di lapide con scritto sepulcrum Proti M. Nella tomba furono rinvenute ossa bruciacchiate, indizio del genere di martirio subito da Giacinto. Dato che la tomba era molto scarna si è pensato che fosse stata scavata durante la persecuzione di Valeriano allorquando era proibito ai cristiani l'accesso ai sepolcri. Attualmente le ossa di Giacinto sono venerate nel collegio di Propaganda Fide; mentre quelle di Proto in San Giovanni dei Fiorentini. La festa di entrambi si celebra l'11 sett.
I fatti della vita di Proto e Giacinto sono invece contenuti in una narrazione assolutamente leggendaria: in essa si dice che erano due fratelli eunuchi schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. In questa località i due giovani cristiani riuscirono a far entrare Eugenia in un monastero. In seguito a romanzesche vicende la famiglia di Filippo si convertì, Eugenia rientrò poi a Roma e svolse opera di apostolato; all'amica Bassilla, desiderosa di aderire al Cristianesimo, consegnò i suoi schiavi Proto e Giacinto perché la istruissero nella verità di fede. Dopo la conversione Bassilla fu denunciata dal fidanzato al magistrato che la fece condannare a morte assieme ai due giovani.
In alcune leggende romane si riscontrano altri gruppi di giovani eunuchi al servizio di donne: come Calogero e Partenio, Giovanni e Paolo; si tratta quindi di un motivo comune e ricorrente. Che Proto e Giacinto fossero fratelli è già affermato da Damaso, ma in mancanza di documenti più sicuri non si può escludere che la notizia sia leggendaria. Forse essa è nata dal fatto che i due martiri furono sepolti l'uno vicino all'altro. Non è infrequente il caso, in questo genere di narrazioni, di trasformare in parenti, martiri sepolti nella stessa zona. (Autore: Gian Domenico Gordini -

20 San Sacerdote di Lione -
Martirologio Romano: A Parigi in Francia, transito di san Sacerdote, vescovo di Lione, che visse nell’amore e nel timore di Dio e morì in questa città, dove era giunto per un concilio.
Giaculatoria -

21 Santa Sperandea (Sperandia) -
Gubbio, 1216 -
La vita di Santa Sperandia è da inserirsi, nel movimento del beghinismo femminile, ortodosso, che nel secolo XIII era largamente diffuso nell'Italia centrale.
Il movimento era formato da donne pie e religiose che, pur restando nel mondo, dedicavano lo loro vita ad atti di pietà e di carità cristiana, pellegrinando di luogo in luogo fino a che non si riunivano sotto la guida dei principali ordini monastici.
Così fu anche per Santa Sperandia che solo alla fine della sua vita si ritirò nel monastero delle benedettine di Cingoli.
Etimologia: Sperandia = Spera in Dio
Sperandia nacque a Gubbio, in Umbria, si presume intorno al 1216 e morì nell'anno 1276. Visse, quindi, in un periodo ed in una regione in cui l'ideale di povertà evangelica proposto da S. Francesco attirava una miriade di proseliti.
All'età di nove anni a S. Sperandia apparve Gesù che le rivelò che doveva spogliarsi delle sue vesti e fare penitenza. Lo spogliarsi delle vesti indicava il distacco dei beni materiali per una scelta totale di quelli spirituali.
La Santa si rivestì di una ispida pelle di maiale, con un cintura di ferro ai fianchi e si allontanò dalla famiglia per seguire la chiamata del Signore. Tutta la vita di Santa Sperandia fu pervasa da un'ansia profonda di preghiera e soprattutto dalla meditazione della Passione di Cristo. Tale meditazione fu spesso preludio di estasi e visioni allegoriche, specialmente nel giorno del Venerdì santo.
La preghiera era anche accompagnata da un'aspra vita penitenziale, fatta di astinenze e lunghi digiuni quaresimali. L'ultima quaresima della sua vita la santa la trascorse nel territorio di Cingoli,  al "Sasso di Citona", luogo oggi chiamato "Grotte di santa Sperandia". Sperandia trascorse al freddo quei quaranta giorni della quaresima di San Martino, senza tunica, a capo scoperto e a piedi nudi, chiusa in una capanna di stuoie.
al "Sasso di Citona", luogo oggi chiamato "Grotte di santa Sperandia". Sperandia trascorse al freddo quei quaranta giorni della quaresima di San Martino, senza tunica, a capo scoperto e a piedi nudi, chiusa in una capanna di stuoie.
Ad un'anima così eletta il Signore non negò il carisma dei miracoli, che attrasse verso la santa, sia durante la vita che dopo la morte, una moltitudine di devoti. Con il segno della croce, la santa operava prodigi, con particolare predilezione verso i fanciulli infermi, le donne sterili e i carcerati. Un altro tratto della sua vocazione, fu la carità verso i poveri, ai quali rivolgeva parole fervide di fede e di speranza, come le seguenti: "il Signore provvederà", "confida nel Signore", etc.
La Santa veniva anche chiamata a dirimere le discordie fra città o anche all'interno della stessa città fra le diverse fazioni dei guelfi e ghibellini. Sperandia fu, inoltre, una santa itinerante, dall'inizio della sua vocazione fin verso gli ultimi tempi della sua vita. Ella , come molti santi e religiosi del Medioevo, intendeva imitare Cristo, itinerante per le contrade della Palestina, il quale disse: "gli uccelli dell'aria hanno i propri nidi, le volpi le proprie tane, ma il Figlio dell'uomo non ha dove riporre il capo".
Tale imitazione voleva anche sensibilmente testimoniare ai fedeli il radicale distacco dai beni terreni. La vita peregrinante permetteva a Santa Sperandia e ad altri come lei di transitare in numerose città e borghi e di edificare i cristiani con la parola, con l'esempio e con i prodigi. Santa Sperandia visitò Roma, Spoleto, Gubbio, Recanati, Fossato di Vico, Fabriano, Cagli e la tradizione la vuole anche pellegrina in Terra Santa. Dopo lunghe peregrinazioni, la santa stabilì la sua dimora a Cingoli, vestendo l'abito di San Benedetto nel Monastero di San Michele. A motivo della sua santità ed autorità, venne anche eletta all'ufficio di abbadessa.
La tradizione tramanda anche il celebre miracolo delle ciliegie. Nel mese di gennaio la santa aveva chiamato alcuni muratori per il restauro e l'ampliamento del monastero. Preparò loro da mangiare e a fine pasto chiese loro se avessero avuto bisogno di qualcos'altro.
I muratori, presi da spirito goliardico, risposero che avrebbero gradito delle ciliegie fresche. La santa, dopo aver fatto ricorso alla preghiera, vide apparirgli un angelo in atto di porgerle un cesto di ciliegie. Santa Sperandia le portò ai muratori, i quali sbalorditi per il prodigio, si gettarono ai suoi piedi, chiedendole perdono per l'insulsa ed irriverente beffa. Santa Sperandia morì l'11 settembre 1276.
La sua sepoltura divenne subito meta di pellegrinaggi e luogo di grazie e di miracoli. Il suo corpo incorrotto è esposto alla venerazione dei fedeli nel monastero benedettino propriamente detto di santa Sperandia a Cingoli. (Autore: Elisabetta Nardi – Fonte: Enciclopedia dei Santi)
Giaculatoria -

22 Santi Vincenzo, Ramiro e compagni -
Una tardiva ‘Passio’ racconta che s. Vincenzo abate di S. Claudio, monastero sito nella città di León in Spagna, rimase vittima di una persecuzione che Riciliano, ultimo re degli svevi, ariano, aveva scatenato contro i cattolici, nella seconda metà del secolo VI.
Vincenzo fu condotto davanti ad un tribunale e qui professò la sua fede cattolica, parlando apertamente contro gli ariani, che professavano la eresia di Ario (280-
La condanna degli eretici da parte di due Concili, instaurò una lotta non solo ideologica fra il cristianesimo ufficiale ed i fautori dell’eresia.
Per la sua intransigenza dottrinaria, Vincenzo venne decapitato l’11 marzo e sepolto nella chiesa del suo monastero; secondo l’iscrizione sulla lastra della tomba, sarebbe morto nel 630.
Due giorni dopo il suo martirio, vennero uccisi anche Ramiro, priore dello stesso monastero e dodici monaci; del martirio di questo gruppo esistono altre due ‘passiones’ anch’esse tardive e leggendarie.
Le reliquie dell’abate Vincenzo furono in seguito trasferite ad Oviedo, dove ancora si conservano nella cosiddetta ‘Camera Santa’ della cattedrale.
Invece le reliquie di Ramiro e dei dodici monaci, furono trasferite nella cattedrale di León, il 26 aprile 1596. La festa di tutti ricorre a León l’11 marzo, mentre nei martirologi benedettini ricorre l’11 settembre, data riportata anche dal ‘Martirologio Romano’. (Autore: Antonio Borrelli -

